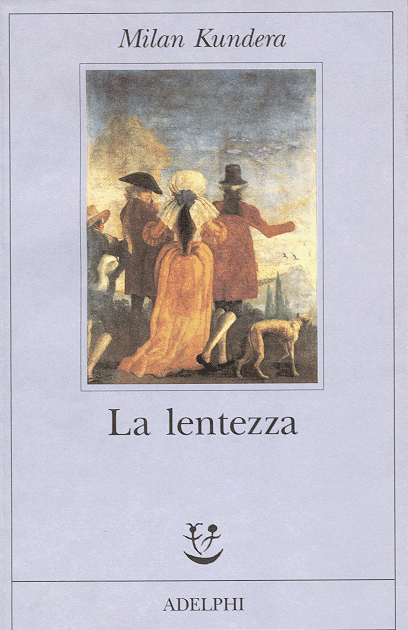Diario da Osaka 2 : ecco arrivata per i lettori di Young la seconda corrispondenza giapponese dal nostro amico il baritono e regista Marcello Lippi che nel Diario da Osaka n. 1 ci aveva raccontato di essere arrivato in Giappone perchè ingaggiato dalla prestigiosa Opera Kansai Nikikai per la regia del “Trittico” di Puccini –Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi- che debutterà ad Osaka il prossimo 25 giugno 2016. Marcello Lippi, anche direttore artistico della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, si trova dunque alle prese con una compagnia di ben 58 artisti giapponesi ai quali, oltre a dirigerli, sta letteralmente insegnando a “essere” italiani per poter scendere nei panni dei personaggi dell’opera pucciniana. Questo insegnamento dell’italianità agli artisti Giapponesi diventa gioco forza anche una discesa dentro se stesso, dentro la propria matrice culturale, facendoci entrare nei segreti alchemici dell’anima di un artista italiano contemporaneo. Omericamente parlando Marcello Lippi è veramente uomo dal multiforme ingegno, come dimostra il talento letterario di questo diario giapponese che sta scrivendo rubando spazi creativi all’allestimento in estremo oriente di un imponente trittico d’opera lirica pucciniano, per i lettori di Young e di cui gli siamo infinitamente grati.
David Colantoni
DIARIO DA OSAKA – N 2, 9 giugno 2016
Di Marcello Lippi

Marcello Lippi Baritono e Direttore Artistico direttore artistico della Fondazione Teatro Verdi di Pisa.
Hayaku, veloce, in fretta!!! Il tempo non si concede pause qui ad Osaka e sembra che scorra molto più rapidamente; i ristoranti funzionano a pieno ritmo tutto il giorno, non c’è orario per mangiare! I clienti si succedono velocemente sulle sedie intorno ad un nastro rotante dal quale prendono al volo i piatti al passaggio e consumano in fretta un pranzo che è tempo rubato al lavoro in un paese che non ha nemmeno un giorno libero durante la settimana. Tanti piccoli gesti meccanici, tanti piccoli piedi che si muovono velocemente ed ordinatamente secondo le leggi non scritte dell’educazione e di un’encomiabile onestà che è identità del popolo giapponese. Distratto come sono, dimentico sempre di ritirare il resto e non c’è stata una sola volta che qualcuno non mi abbia inseguito per riconsegnarmelo. Onestà, rettitudine, senso dell’onore. Non voglio pensare all’Italia di oggi dei furbetti, dei rubagalline e dei grandi ladri impuniti, non ci voglio pensare quaggiù! Ripenso invece al mirabile saggio di Milan Kundera “La lentezza” (La lenteur) del 1995 con quell’immagine stupenda dell’uomo intento a “contemplare le finestre del Buon Dio” cioè a guardare il cielo, e avverto una profonda differenza. Qui tutto è veloce, ma perché in fondo? Scendo dall’albergo, che dista pochi minuti dal teatro. Alla reception c’è il responsabile della produzione, trafelato, che evidentemente ha corso fino all’hotel e che mi sussurra con affanno “Maestro, cosa è successo?”. Mi fa percorrere i 3 minuti di strada come se fossimo alla maratona di Osaka (non so se esista, ma sicuramente non servirebbe) e quando arrivo, la mia assistente, preoccupatissima mi dice: “Maestro, cosa è successo?”. Impensabile avere quei trenta secondi di ritardo che avevo. Io ci vivo bene nella velocità, intendiamoci, non riuscirei ad avere vent’anni come ho, pur avendone molti, ma molti di più nel mio involucro esterno. Sono rimasto laggiù, agli anni dell’università, e sto ancora contemplando le finestre del buon Dio (che maniera stupenda di definire l’ozio contemplativo!). Provo gusto di una frase elegante, di un’intesa spirituale, di un cenno che sostituisca la dichiarazione esplicita, di un’allusione invece che di una chiara invasione di campo, come usa tanto oggi. Mi sento appagato quando incontro un’anima viva, d’intelligenza vivace, pronta a cogliere un sottile umorismo o a leggere in cuore ciò che non viene detto. Questa natura serotina, amante del mistero, del non-detto, della profondità e non dell’apparenza mi deriva sicuramente dalle molte letture romantiche dei grandi autori dell’ottocento, nelle quali trovavo preziosi insegnamenti per fare dell’opera d’arte la mia vita e la mia vita un’opera d’arte. Intanto, però, continuo a correre, mentre a riposare pensa quel ragazzo che vive in me, come padrone di casa, che pensa a dipingere con le dita nuvole nel cielo, a scrivere e cantare nell’alba fresca, come nel tramonto, una musica che non gli appartiene, ma è segno distintivo della più alta forma di libertà: l’appartenenza.
E’ tardi, il tempo scorre inesorabilmente veloce e vorrei essere nel Settecento, al tempo di Madame de T., quando c’era il tempo di gustare l’istante totalmente, bello o brutto che fosse, con coraggio, con passione; quando una cosa andava intuita; quando si parlava e si sapeva parlare, guardare un oggetto e conoscerlo, una persona ed amarla, un paesaggio e perdervicisi. “C’è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra velocità e oblio. Prendiamo una situazione delle più banali: un uomo cammina per la strada. A un tratto cerca di ricordare qualcosa, che però gli sfugge. Allora, istintivamente, rallenta il passo. Chi invece vuole dimenticare un evento penoso appena vissuto accelera inconsapevolmente la sua andatura, come per allontanarsi da qualcosa che sente ancora troppo vicino a sé nel tempo. Nella matematica esistenziale questa esperienza assume la forma di due equazioni elementari: il grado di lentezza è direttamente proporzionale all’intensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio.” (ibidem)
Ho citato questa frase perché me la sono segnata sull’agenda, (spero di averla riportata correttamente), quando anni fa lessi quel saggio; volevo farne carne, per non perdermi nulla di quanto mi è stato dato, nemmeno un viso, nemmeno una situazione. Ho reso i miei occhi acuti, questo sì, la mia mente penetrante, la mia insofferenza verso il superficiale, il banale, il volgare ha toccato vette assolute…ma non ho rallentato, accidenti! Ed in questi giorni nipponici corro come tutti perché “è tardi” e permetto a persone semisconosciute di rubarmi il tempo sui social, ai doveri della managerialità di sovrastare le mie necessità artistiche e dimentico, annullo, cancello, con l’amara coscienza di averlo fatto. Questa sera in teatro ho raccontato ancora ai cantanti la nostra anima italiana: ho spiegato un rapporto di coppia consunto come quello dei protagonisti del Tabarro; ho spiegato lo sguardo che dice assai più della parola, quello tra i due amanti che non vogliono essere scoperti e si cercano con passione mentre sono al lavoro; ho spiegato come si abbracciano pieni di fuoco due innamorati nell’unico momento rubato alla loro miserabile situazione nel quale riescono a ricongiungersi; ho spiegato cosa significa aver perso un figlio, non aver prospettive nella vita, sopravvivere per un pezzo di pane senza alzare lo sguardo più al cielo. Ma soprattutto ho fatto vedere come ci muoviamo noi italiani per esprimere tutto ciò; con una naturalezza che noi abbiamo, loro no, ho spiegato come essere attori con tutto il corpo, non attraverso smorfie stereotipate del viso e non solo con gli arti: ho detto loro che se non sentono questo dentro il cuore non lo riusciranno mai a rappresentare bene. Chiedo loro di respirare come me, di emozionarsi come me, di accettare la sfida con il personaggio fino alle estreme conseguenze.
E’ una concezione che non hanno quella del teatro che nasce dal cuore, del gesto non studiato, ma necessario, significante, immediato: solo quel gesto e non un altro, la “necessità scenica”. Lo sapranno portare anche nella vita? Per la stragrande maggioranza delle persone un gesto è insignificante, spesso meccanico, un tic, involontario ed incosciente. Il gesto è invece ciò che trasmette la memoria di noi al mondo e la memoria del mondo a noi. Siccome oggi mi sono svegliato Kunderiano, appartiene a noi il nostro gesto o noi apparteniamo al nostro gesto? (cfr. L’insostenibile leggerezza dell’essere): il gesto semplice di ravviarsi i capelli per una donna può essere una comunicazione, un tic, una manifestazione di disagio o nervosismo e chi la vede capirà da quel gesto cose che possono appartenere solo a lei o essere anima di un popolo o dell’intera umanità, perché quel gesto, fatto così e non altrimenti, apre ricordi su altre persone che lo hanno già compiuto in quel modo o stupisce con la sua novità e diventa memoria in futuro di quell’istante magico. Dopo aver ripreso il lavoro fatto ieri con il Tabarro, mi sono quindi immerso nella vita di convento di “suor Angelica”, spiegando ancora il “modus vivendi” di una suora cattolica a chi non sa nemmeno cosa sia la mia religione. E’ un gioco, nel quale le due civiltà a confronto si conoscono e prendono coscienza della propria identità, alla ricerca di un “gesto” scenico necessario, identificante, che avvicini ed unisca i nostri popoli tra loro e con tutto il mondo, di un uguale sentire, di una fratellanza.
—————————————-