Il Maggio Musicale Fiorentino è una realtà viva del nostro panorama musicale, un teatro coraggioso e intelligente che tenta strade nuove, incoraggia, promuove, sostiene, pur nel difficile momento che attraversano i teatri italiani, il nostro patrimonio culturale. L’idea di un Festival pucciniano settembrino, in teatro, ideale prosecuzione del festival di Torre del Lago e in attesa di un futuro ipotetico festival lucchese, è intelligente ed efficace. Proponendo celebri opere del Maestro in settembre intercetta infatti i flussi turistici che confluiscono in questo periodo tardo estivo-autunnale verso la città d’arte e propone un affascinante modo di trascorrere le serate ai turisti e al pubblico cittadino. Meritorio!
Plaudo quindi alla novità di questo festival, come a ogni cosa che aiuti ad arrestare il percorso di imbarbarimento culturale foriero di gravi conseguenze sul piano sociale, ma plaudo soprattutto all’intelligente collocazione temporale e al lavoro di approfondimento che accompagna le esecuzioni in palcoscenico, sviluppato attraverso incontri pomeridiani con esperti, tra i quali il fraterno amico Cesare Orselli, e la visione dello sceneggiato “Puccini” di Sandro Bolchi. Chi ne ha desiderio può quindi dedicare il mese a un viaggio meraviglioso nella vita e nella musica del Lucchese.
Tre le opere in cartellone: Madama Butterfly, La Bohème e Tosca, ossia le sue opere più celebri per il grande pubblico. Ideale come partenza, intelligente debutto d’una novità che spero non rimanga un episodio isolato. Già nel 2008-9 il teatro fiorentino aveva infatti tentato un’operazione simile con “Recondita armonia”, ma non ebbe seguito. Speriamo che “Passione Puccini”, invece, si radichi, prendendo energia da un teatro, come quello di ieri sera, quasi colmo di spettatori.
Un secondo motivo di plauso è il tentativo del Maggio Fiorentino di confrontarsi con una programmazione festivaliera, inedita per un grande teatro italiano, ma normale in molti paesi all’estero. La programmazione festivaliera comporta infatti che ci sia un titolo diverso quasi ogni sera, con l’esigenza ogni giorno di smontare e rimontare le scenografie, impegno gravoso per le squadre tecniche.
Dal punto di vista organizzativo il problema maggiore è quello della disponibilità del palcoscenico che, se impegnato dalle prove di un’opera, non può esserlo per quelle di un’altra, con riduzione del tempo di prova e necessaria semplificazione dell’apparato scenografico per sveltire i cambi. Se questo ha portato in Germania a un teatro essenziale, spesso irritante, con minimalismo scenico esasperato tanto che non è difficile assistere a un Giulio Cesare di Haendel e a un Ballo in Maschera di Verdi che impieghino le stesse scenografie e gli stessi costumi (abiti neri e cappotti lunghi militareschi), nel caso della Bohème dell’Opera di Firenze si è adottata sì una forte semplificazione scenica, ma si è salvaguardata la classicità dell’ambientazione e dei costumi.
Le scene di Tiziano Santi (che cura tutta la trilogia secondo un progetto unitario) hanno dato un’idea d’essenzialità, privilegiando la praticità e la rapidità di mobilitazione degli elementi, soprattutto a causa della scelta di accorpare i quadri, facendo un solo intervallo. Povera la soffitta dev’essere, ma così piccola, con tutto quel palcoscenico vuoto attorno, dava un effetto d’eccessiva essenzialità; per cambiare dal primo al secondo quadro, avrei personalmente preferito attendere un minuto di più in silenzio piuttosto che vedere Mimì e Rodolfo uscire in proscenio e sentire il delicatissimo finale del duetto stesso rovinato dai rumori del cambio scena.
Brutto l’inizio del secondo quadro, a scena vuota per ritardare la comparsa del Café Momus: questo è usato dalla regia in modo confuso, inizialmente come un interno, infatti il coro esce dalla porta centrale per andarsene con Parpignol, poi come esterno, quando passa il Tambur Maggiore e quando Alcindoro dice “Come, qui fuori?”. Bellissimo invece l’effetto delle proiezioni nel terzo atto che raggiunge un effetto di vera poesia, assolutamente commovente. Efficaci e classici i costumi di Angela Giulia Toso e belle le luci di D.M.Wood. L’orchestra del Maggio è una realtà tra le migliori del nostro panorama e lo ha dimostrato anche ieri sera, guidata da una bacchetta giovane, ma validissima, quella di Francesco Ivan Ciampa, che già aveva fatto alcune recite nel 2016 riprendendo Daniel Oren. Sicuro nella direzione, attento ai colori e alle espressioni, ha mantenuto un ottimo rapporto con il palcoscenico, imponendo le proprie idee, a costo a volte di costringere i cantanti a qualche ritardando non proprio di tradizione.
Per entusiasmare un direttore deve lasciare un segno nell’ascoltatore e rimanergli nel cuore: Ciampa lo fa soprattutto nell’ultimo atto con alcuni ritenuti, vere sospensioni del tempo e dello spazio, virtuosismi a fine espressivo che mi hanno commosso, ferito, lasciato inebetito per la loro bellezza. Queste sospensioni erano sospensioni del suo e del nostro cuore, indimenticabile meraviglia! Molto bene il coro del Maggio, diretto da Lorenzo Fratini, anche se dovrebbe essere un po’ più curata l’emissione vocale degli spazzini nel loro episodio.
La direzione artistica del teatro merita un terzo plauso per il cast giovane, come dev’essere per “La bohème”, con cantanti tutti dotati d’un discreto “phisique du rôle”.
Le voci sono leggere, quasi tutte troppo, secondo una moda di questo nostro tempo, ma curate e sicure nell’emissione. Maria Mundryak, se non ha ancora sempre lo spessore vocale giusto e spesso dimentica d’essere malata, è però una interessantissima Mimì, graziosissima nel primo quadro e meravigliosa nell’ultimo. La qualità vocale è di primo livello e poi è molto bella, il che non guasta certo. Matteo Lippi (che non è mio parente) è un buon Rodolfo, forse più adatto ad altri ruoli come Traviata o Elisir, ma tratteggia un personaggio credibile, con grande sicurezza vocale in acuto.
Trovare nel ruolo di Marcello Benjamin Cho è per me poco comprensibile: è vero che il giovane artista è bello e alto, ma il suono della sua voce è molto lontano da quello pucciniano; è una voce potente che raramente trova le risonanze frontali, per cui abbiamo ascoltato vocali inesistenti nel nostro idioma, molto aperte, una zona grave che rasenta l’afonia, suoni non ben proiettati e acuti troppo “liberi” per una tessitura baritonale, oltre a un’innaturalità sostanziale del gesto. Perfetto musicalmente, ha bisogno di ”italianizzare” un poco il suono. Andrea Vincenzo Bonsignore, buon elemento scenicamente e vocalmente, è stato un po’ in difficoltà nel tratteggiare un ruolo difficile come quello di Schaunard, molto basso per un baritono, con puntature improvvise. Non sempre ha avuto sufficiente volume e ha perso a tratti il contatto con il maestro nel suo arioso d’esordio proprio per tentare di “appoggiare” maggiormente alcuni suoni. Angela Nisi, Musetta, penalizzata nello charme da un’inguardabile parrucca rossa, ha fatto poco, come Musetta, per affascinare il pubblico, perfino nella scena della “caviglia”, ma ha eseguito l’aria in modo molto valido, con tanto di buon filato conclusivo per la gioia dei melomani.
Bene Goran Juric, un Colline ben centrato e divertente il Benoit del costariqueño William Hernandez Ramirez, un giovane baritono tra i più promettenti. Un cast tutto giovane ha reso credibile la vicenda, bello l’aspetto visivo, partecipe il pubblico. Ma è mancato ciò che proprio la gioventù del cast avrebbe dovuto assicurare, cioè il brio, la vivacità, il senso del teatro e della situazione. Si è avvertita una grande staticità nello stare sul palcoscenico, cantanti spesso fermi, con il volto verso la platea, attenti giustamente all’aspetto musicale e all’emissione, ma dimentichi delle necessità sceniche, soprattutto nei momenti amorosi. Un vero maestro del palcoscenico è stato invece Alessandro Calamai, Alcindoro, capace di riempire i momenti di silenzio, di non muoversi solo sul canto, ma d’essere “vero” sul palcoscenico, dipingendo mirabilmente un personaggio che egli ha fatto molte volte con successo. I giovani interpreti avrebbero dovuto imitarlo un pochino e trarre profitto dal suo donarsi, dal suo entrare completamente nella situazione, dalla sua profonda maestria. Così non è stato, complice sicuramente, e torniamo alle prime considerazioni, la mancanza di prove dovuta all’alternanza festivaliera delle opere.
Difficile, in quest’occasione, valutare la regia di Bruno Ravella: spesso gli artisti in scena davano l’impressione di non sapere bene cosa fare o di non averlo provato abbastanza, con momenti registici molto belli, come quando Rodolfo si sdraia teneramente nel lettino accanto a Mimì morente, e altri meno belli, come quell’incomprensibile gioco di stracci rossi che vorrebbe creare un siparietto dei pupi, che, se funziona nel finto duello dell’ultimo quadro, non funziona nel primo, o come l’arrivo di Mimì nel primo quadro che avviene dal palcoscenico vuoto, non dalla scala che gli altri personaggi ci hanno fatto immaginare, come se la ragazza scendesse da un’astronave; non belle le stelle che si accendono una ad una come lampadine, anche se l’effetto complessivo finale a stelle accese è gradevole; incomprensibile l’altalena che scende per l’aria di Musetta, ma non viene utilizzata; forzato e scontato il fatto che nell’ultimo quadro si passi di colpo, con l’entrata di Mimì, da un fulgido sole primaverile alla notte con le solite stelle! Molte le scene nelle quali gli artisti pensano quasi solo a cantare, dal corteggiamento del primo quadro a una scena al caffè Momus tra le più statiche mai viste, con esibizione tardiva della caviglia (e quindi ingiustificata reazione di Marcello) e della scarpetta. Ma come rimproverare la regia?
Non è difficile pensare abbia avuto poche prove a disposizione e che queste mancanze non dipendano dal regista. Certo poteva far muovere i giovani con più disinvoltura e non limitarsi a farli muovere quando cantano, per giunta con una fisicità eccessivamente “rilassata”. L’attrezzeria era quasi inesistente ed è dispiaciuto vedere le lattivendole con i cesti vuoti cantare “Polli ed ova”: ci sarebbe voluto davvero poco a procurarglieli e a renderli visibili al pubblico. Tra i molti momenti belli ricordiamo l’incantevole entrata di Mimì nel terzo quadro (il più bello in assoluto) su un manto di neve e la citazione di “Napoli milionaria!” di De Filippo all’entrata di Benoit. L’operazione in generale merita un’entusiastica approvazione con un ringraziamento speciale a direttore e regista che, nelle difficili condizioni di un debutto festivaliero che seguiva a ridosso quello di “Madama Butterfly”, hanno dato il massimo dell’impegno e della disponibilità per farci sognare sulle note meravigliose di Puccini.
———————————————————————————————————————————————————————————————————–
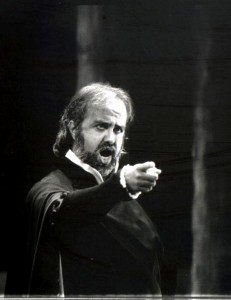
MARCELLO LIPPI
Autore e Critico Musicale per la Cultura di Young diretta da David Colantoni













