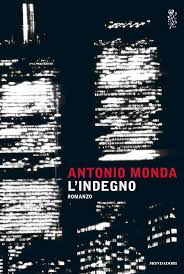Non conoscendo parenti o amici di Muhammed Ali non appena ho saputo la notizia della sua morte il primo impulso che ho avuto è stato quello di fare le condoglianze al mio amico Antonio Monda. Infatti egli è la persona che io conosco più intimamente legata alla boxe nel suo aspetto simbolico, oltre che sportivo, nel suo essere anche uno straordinario catalogo omerico delle metafore della vita in quanto sfida leale grandiosa e terribile allo stesso tempo. Questo perché ho letto i suoi quattro romanzi , di cui l’ultimo, L’indegno,è uscito a marzo di quest’anno, che sono i libri che vanno a costituire i primi 4 movimenti del grande progetto che egli sta scrivendo di una decalogia sulla New York del 900, vasto progetto narrativo di cui ho più ampiamente parlato in Ota Benga, la decalogia americana di Antonio Monda , narrazione che ha come filo conduttore, che la attraverserà in tutta la sua estensione , proprio la boxe, nel racconto dei più grandi incontri del 900.
E proprio a Muhammad Ali , come profeticamente presagendo che sarebbe a breve scomparso, Antonio Monda ha dedicato questo tributo nell’ Indegno, il 4 romanzo della decalogia New yorkese, eccolo: “Aveva organizzato la visione dell’incontro nel piccolo studio accanto alla mensa, dove c’era l’unica televisione del seminario, un vecchio e rumoroso apparecchio in bianco e nero dal quale provenivano immagini distorte. Non era l’unico a voler vedere il combattimento, si erano uniti a noi padre Harrigan, un anziano sacerdote irlandese, e padre Lowry, che aveva la sua stessa età, ma si teneva in forma facendo jogging dopo la messa mattutina: i parrocchiani lo chiamavano “padre Olimpico”. Insieme a loro c’era anche Marlon, un giovane seminarista giamaicano, felicissimo di trovare un gruppo di appassionati. All’ultimo momento si aggiunsero anche le suore che vivono con noi in parrocchia, le quali portarono due buste di patatine e si misero in un angolo: ebbi l’impressione che fossero più interessate a noi che alla sfida, e chiesero di lasciare accesa la luce al neon. La più giovane, di nome Beatrice, servì anche della Coca-Cola, calda e sgasata, mentre la più anziana, Lorraine, continuava a fissarmi negli occhi. Ho sempre l’impressione, il timore dovrei dire, che sappia tutto di me, e quando viene a comunicarsi mi sfiora le mani: carezza, un monito, non so. E io mi sento nudo sino alle viscere. Padre John diceva che è la più intelligente di tutta la parrocchia, e poi aggiungeva: «Nel senso etimologico di intus legere». Forse anche lui sapeva tutto di me.
Quella sera pendevamo tutti dalle sue labbra, e quel prete appassionato di boxe ci spiegò che il match andava ben oltre una sfida sportiva: si affrontavano George Foreman e Mohammad Ali, due grandi campioni che interpretavano lo sport, e la vita stessa, in maniera opposta. Era la sfida della forza contro l’intelligenza, la potenza contro la velocità, l’abnegazione contro il talento. Il campione in carica era Foreman, e aveva demolito sia Joe Frazier che Ken Norton, gli unici due pugili che erano riusciti a domare colui che continuava ancora a definirsi il più grande. Non c’era nessuno che credeva che Ali potesse farcela: era più anziano e logoro di Foreman, e gli anni d’inattività ne avevano appesantito il fisico, e forse anche il genio. Persino nel suo entourage c’era molta sfiducia, e i più intimi erano terrorizzati che solo l’orgoglio, che non gli aveva fatto piegare la testa neanche di fronte al governo americano, lo avrebbe tenuto in piedi mentre andava incontro a una sicura, devastante punizione. Ma lui non aveva paura, era una delle caratteristiche del suo talento, e rispondeva “stasera danzeremo” alle smorfie di angoscia di Bundini Brown, l’amico che lo aveva seguito in ogni battaglia. E poi lo ripeteva e ripeteva, quasi cantando: era il ritornello che avrebbe rotto il sortilegio. E Bundini cercava di sorridere, ma era terrorizzato.
Padre John sapeva i nomi di tutti i membri dell’entourage e si divertiva a riconoscerli sullo schermo: «Quello è Angelo Dundee, e quello è Ferdie Pacheco, Ali non se ne priverebbe mai», e proprio in quel momento vedemmo che ripeteva anche a lui “stasera danzeremo”, sorridendo come un bambino. Padre John disse anche che Ali era un musulmano nero, ma a nessuno, lì dentro, sembrava un dato importante.
Anche il luogo era epico, ci spiegava: da quelle terre pro- venivano gli antenati di tanti campioni del passato, forse anche dei due contendenti di quella sera, ma ora lo Zaire era governato da Mobutu Sese Seko, un dittatore spietato, che aveva ospitato l’evento per promuovere un’immagine di potenza e centralità. Per assicurare la diretta televisiva in un buon orario per l’America aveva accettato che l’incontro si disputasse alle quattro del mattino, ma non c’era nessuno tra i sessantamila spettatori presenti allo stadio che sentisse la stanchezza. E il dittatore, nel palco presidenziale, esibiva al mondo intero il copricapo di pelle di leopardo e il sorriso tirato di chi ha inflitto molto dolore.
Quando Mohammad Ali apparve sullo schermo, Marlon si alzò in piedi e cominciò a esultare, poi si rimise a sedere, intimidito dalla propria esplosione di entusiasmo. Le monache sorrisero, mentre i due preti anziani borbottarono qualcosa senza prendere parte. Sorrise anche padre John, che amava il coraggio di Ali, e sperava che quella notte facesse rivivere Davide contro Golia. Spiegò che non ci sarebbero state vie di mezzo: quella sfida avrebbe segnato la sua fine, o lo avrebbe consacrato come il più grande di sempre.
Foreman faceva paura: era gigantesco, e nei suoi occhi non si vedeva la luce. Era quello che terrorizzava i secondi di Ali, i suoi tifosi, e Marlon che rimaneva a stento seduto.
Era quello che inquietava anche me: quello sguardo prometteva dolore, ma in qualche modo era più sincero di quello sfrontato e scherzoso di Ali, che aveva a sua volta bisogno di far male, di ferire, dominare, umiliare. Pensai che anche Davide era sfrontato, e aveva molto da farsi perdonare: noi preti riportiamo ogni cosa alla Bibbia.
Si fissarono negli occhi senza battere ciglio mentre l’arbitro dava gli ultimi avvertimenti. Non ascoltarono una parola di quello che diceva, eppure Zach Clayton, questo era il suo nome, urlava, voleva essere udito dal mondo intero. Ma i due sfidanti conoscevano le regole a memoria, e sapevano che in quel momento era in gioco ben altro: chi reggeva lo sguardo, e dimostrava di non avere alcuna paura per quella promessa di dolore, avrebbe vinto l’incontro.
Lo capirono tutti, allo stadio, e lo capimmo anche noi: in quei pochi secondi senza tempo si sentì solo il silenzio. Poi il boato del pubblico, fortissimo, selvaggio, estenuato: il preludio di una liturgia di trionfo e di morte.
Quando Ali raggiunse l’angolo per attendere il suono del primo gong, volse le spalle al rivale e iniziò a incitare la folla dello stadio che tifava tutta per lui.
Era alto, bello, con un corpo nobile, da principe africano. Appena alzò le braccia al cielo si misero tutti a gridare, e gridò anche lui, mentre guidava la folla come un direttore d’orchestra, e il pubblico urlò all’unisono: «Boma Ye! Boma Ye!».
Non riuscivamo a comprendere, nella nostra stanza illuminata al neon. Neanche padre John conosceva il significato di quelle parole, ma poi il telecronista spiegò che significa “uccidilo”, e lo ripetevano tutti, sempre più forte.
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
La boxe è anche questo, inutile negarlo.
Padre John non disse niente, non ne aveva bisogno, e
continuò a fissare il monitor in bianco e nero, pregando che non si spegnesse proprio allora: chissà di che colore erano i mutandoni di Foreman. E fissava il monitor suor Lorraine, immalinconita da quell’urlo di morte.
Allo scoccare del gong Foreman raggiunse il centro del ring e fece esplodere due diretti di una potenza impressionante, voleva chiudere l’incontro al più presto, come aveva fatto con Frazier, schiantato al tappeto sei volte in due riprese. Ma Ali ritrasse il proprio corpo di pochi centimetri, e riuscì ad attutire l’impatto dei pugni. Nessun pugile era in grado di realizzare questa mossa difensiva con tanta grazia e velocità. E lui lo fece con un sorriso appena accennato, perché sapeva di essere il più grande. Poi, un attimo dopo, lanciò a sua volta una combinazione di diretti al volto: veloci, perfidi, strafottenti. E Foreman lo guardò attonito.
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
Non si era mai visto nulla di simile: il primo round è
quello dello studio, della prudenza, della difesa. E Ali stava sorridendo, mentre rispondeva colpo su colpo e allargava la guardia, per dimostrare di non avere paura, quella notte avrebbe danzato.
La vita non è mai come programmiamo che sia, me lo stava ricordando anche quel rito brutale, animalesco, antico come il sopruso e il dolore. Lo sapevano anche i due rivali, che in quel momento si intrecciarono in clinch e poi tornarono nuovamente all’assalto con diretti esplosivi, implacabili, assassini.
Ali cominciò a danzare, come solo lui sapeva fare, perché lo aveva promesso ai suoi amici e al mondo intero: non avrebbe fatto la fine di Frazier e Norton, e quell’immondo scimmione che aveva di fronte era solo un usurpatore.
Il pubblico capì immediatamente quanto stava succedendo e impazzì di gioia: l’urlo rimbombò per tutto lo stadio, lungo il fiume Congo e poi nel cuore nero della foresta, sempre più forte, sempre più estasiato. E quell’orgasmo arrivò sino a noi, e in ogni parte del mondo.
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
I due campioni continuavano a colpirsi mentre si fissavano negli occhi, sapevano entrambi che non ci sarebbe stata una seconda possibilità. E lo sapeva il pubblico in delirio, Mobutu con il suo copricapo di leopardo, e il nostro piccolo gruppo guidato da padre John nell’ufficio accanto alla mensa.
No, non poteva esistere altro, quella notte, e Marlon esultava a ogni colpo, perché Ali doveva vincere anche per lui, per la sua gente, per chi non chinava il capo, e non aveva né talento né speranza.
Ma i colpi di Foreman erano di una potenza devastante: Ali riuscì a schivarli e contenerli nei primi due round, ma poi il dolore cominciò a farsi sentire e iniziò ad arretrare verso le corde, dove Foreman lo costrinse a subire una punizione impressionante. Colpiva a braccia larghe sui fianchi, sullo stomaco, sul collo, e Ali rintuzzava e stringeva i denti, reagendo improvvisamente con combinazioni sul volto. Rapide, irridenti, piene di veleno.
A partire dalla quarta ripresa si appoggiò direttamente sulle corde, come se volesse invitare l’avversario a colpirlo. Foreman non aspettava altro, e colpiva e colpiva, sa- pendo che prima o poi Ali sarebbe crollato. Nessun uomo al mondo poteva resistere ai suoi pugni.
Ma Ali invece resisteva, con superbia, con rabbia, perché era nato per dimostrare al mondo intero di che pasta era fatto, e quella sarebbe stata la sua notte.
Lo stadio divenne più silenzioso e i colpi si fecero sempre più violenti: Foreman voleva schiantarlo, quell’arrogante che non mostrava alcun segno di paura; voleva ucciderlo, quello sbruffone che sorrideva subito dopo aver tradito una smorfia di dolore. E continuò a colpirlo sulle costole, voleva frantumarle, polverizzarle, ma Ali non cedeva: quello scimmione senza talento poteva distruggere campioni come Frazier e Norton, ma non lui, il più grande.
La sfida continuò inesorabile, finché nel quinto round qualcosa cominciò a rallentare nei colpi di Foreman: si era stancato di colpire più di quanto Ali fosse stanco di subire. E in un momento in cui prese fiato, Ali sfoderò all’improv- viso una combinazione di due fulmini, entrambi scagliati con il destro, che girarono di netto il volto di Foreman facendo esplodere nuovamente tutto lo stadio:
«Ali Boma Ye!»
«Ali Boma Ye!»
«Ali Boma Ye!»
Lo colpì di nuovo, sul collo, sugli occhi e poi sul naso, e soltanto il gong salvò Foreman da un’umiliazione più dura. Il campione in carica ritornò al suo angolo frastornato, incredulo, furibondo, mentre Ali si rivolse al pubblico e guidò l’urlo di estasi:
«Ali Boma Ye!»
«Ali Boma Ye!»
«Ali Boma Ye!»
All’inizio del sesto round Foreman comprese che l’incontro rifiutava il proprio destino, e che doveva giocarsi il tutto per tutto: riprese a colpire Ali con furia, con dispe- razione, con livore, nessuno aveva mai osato trattarlo così. E Ali si appoggiò di nuovo sulle corde, sembrava quasi divertito di ricevere quei colpi devastanti, e dimostrare al mondo intero che non lo scalfivano affatto.
Di nuovo smorfie, sorrisi, gesti di esultanza verso il pubblico, mentre i pugni di Foreman erano sempre più lenti, prevedibili, morti. Quel povero campione detestato da tutto lo stadio ansimava, schiumava, non poteva credere che i colpi che avevano demolito ogni sfidante, quei pugni devastanti che avevano ridicolizzato chiunque, non riuscissero a piegare quel pagliaccio che continuava a sorridere.
E cercava di colpirlo ancora e ancora, chiudendolo in un angolo, perché questa era la sua unica speranza, da lì non poteva sfuggire. Ma Ali riusciva a imbrigliarlo, a schivare, a reagire con colpi improvvisi e beffardi. E gli occhi spenti di Foreman mostravano solo impotenza e frustrazione, finché, in un momento di scoramento, al termine dell’ottavo round, allargò per un attimo la guardia. Non aspettava altro, Ali, che lo punì con la ferocia dell’orca assassina che strappa la lingua alla balena. Lo colpì con tre destri consecutivi sul volto, poi con una combinazione di ganci, guardandolo ruotare su se stesso, con gli occhi attoniti. E poi lo finì con due nuovi destri, potentissimi, che lo fecero rotolare al tappeto come una carcassa morta da tempo.
Fu un conteggio lungo, crudele, umiliante, che Foreman ascoltò insieme alle urla che continuavano a invocare la sua morte. E non riuscì a risollevare la propria carcassa dal tappeto.
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
«Boma Ye!»
Finì così quell’incontro, con Marlon che esultava di fronte al televisore in bianco e nero, e suor Lorraine che chiudeva gli occhi, perché la storia del mondo è sempre la stessa. Padre Harrigan si era addormentato dal primo round, mentre padre Olimpico scosse la testa con disappunto, non doveva amare Ali.
Padre John si alzò dalla poltrona e si avviò verso la sua camera con in mano la Coca-Cola calda offerta da suor Beatrice, non c’era bisogno di aggiungere altro. Ma sorrideva alla vita, come sempre” ( da L’indegno- Antonio Monda – Mondadori 2016 )
La morte di certe figure è sempre la morte evangelica di un seme. Scomparso il corpo fisico delle persone che hanno compiuto delle particolari gesta sembra che, proprio come il seme della parabola che deve morire per poter fruttificare, il senso di ciò che sono stati e di ciò che hanno compiuto finalmente fiorisca in una dimensione che tracima la peculiarità della loro scomparsa natura fisica, in questo caso quella di un campione di boxe. Credo che sia per questo motivo, per questa invincibile lievitazione del senso di certe vite dopo che si sono spente, che persino una persona come me, un po superficialmente snob verso certi sport di combattimento, verso certe cose che entusiasmano le masse che io non amo in quanto tali, si ritrovi preda di un silenzioso compiangimento interiore per un uomo storico che non è più, la cui presenza nella contemporaneità aveva molto probabilmente agito, parlo su di me, come il lento e inavvertito rilascio di un farmaco benigno e che la cui scomparsa abbia quindi lasciato l’orma ben visibile di un insospettabile vuoto. Mi manca Muhammad Ali, terribilmente. Non sapendo di lui che pochissime di quelle cose talmente diffuse universalmente nel nostro tempo da non potersi proprio non sapere, appena mi ha colpito la notizia che era morto sono andato a cercarlo nelle immagini che resteranno di lui. Ho passato questi giorni a vedere i suoi combattimenti, o meglio i suoi movimenti coreutici, la sua danza per imbrigliare il demone della violenza trasformandolo in arte e a leggere cose e a sentire quello che aveva detto con una attenzione che rimpiango di non aver avuta verso questa figura prima quando era ancora tra noi uno di noi. probabilmente gli avrei espresso una qualche forma di ringraziamento, perché proprio come sentirete dire da Antonio, è vero che è per tutti noi che egli ha lottato.

Antonio Monda su Muhammad ali – l’articolo di giornale sulla condanna a 5 anni di galera e 10.000 dollari di multa per renitenza alla leva
Aristotele dice che la politica non è per i giovani ma per uomini fatti, perché avendo bisogno di saggezza per esercitarsi, oltre che del possesso della teoria dell’universale ha bisogno dell’esperienza dei particolari, i quali necessitano per essere conosciuti non di studio ma di esperienza: ora io son diventato abbastanza adulto da conoscere gli uomini e il loro spaventoso conformismo che cela una ancora più spaventosa paura, per comprendere l’enormità del coraggio e dell’anticonformismo che Ali ebbe nel rifiutare di andare a fare la guerra in Vietnam decidendo di lasciarsi togliere il titolo e con esso quel prestigio sociale che per un uomo di colore in una america ancora sporca, macchiata di orribile apartheid rappresentava molto di più del proprio valore nominale. Muhammed non sapeva nel momento di quella scelta cosa avrebbe portato il futuro, quali conseguenze avrebbe potuto avere la sua scelta sulla sua vita. Le probabilità che quella scelta decretasse la fine della sua attività sportiva e quindi della sua vita sociale erano molto maggiori a tavolino di quanto poi, miracolosamente, -il miracolo che scaturisce dalle fondamenta nobili della democrazia americana talvolta– invece accadde (la sentenza della corte suprema). Questo gesto di rifiutarsi alla guerra, a quella orribile guerra di aggressione, era un offrire la propria vita, per un ideale di humanitas e giustizia, quasi certamente alla morte sociale, cosa che per le potenzialità che erano nella sua vita, potenzialità di cui era egli perfettamente cosciente, era il gesto di un eroe la cui presenza nella nostra contemporaneità ci ha silenziosamente protetti. Da qui l’improvviso rivelarsi alla sua scomparsa della profondità della sua orma nel nostro tempo.
Ho deciso dunque di ospitare qui anche la bella video testimonianza di Antonio Monda da egli rilasciata a caldo appena scomparso il campione, e a cui, come –uomo nuovo– americano, quale egli è, approdato da una migrazione mediterranea in quei lidi dove poi ha convissuto empaticamente sotto lo stesso cielo del campione in amore di boxe, scrittore di questa immensa decalogia in parte compiuta e di cui la boxe è nume, essendo tra le persone che io conosco perciò quella certamente più familiare al campione, vanno le mie più sentite condoglianze per questa incolmabile perdita. Senza aggiungere più che una ultima piccola riflessione.
Se vado oggi a vedere dal vivo o su You Tube sport di combattimento, trovo un estetica del massacro e della violenza, del ridurre l’altro a carne macellata sempre più trionfante. Ci sono ormai, sempre più frequentati, sport di combattimento di tipo gladiatorio i cui video più clikkati hanno titoli efferati che inneggiano alla più truce violenza pura: i corpi dei lottatori, costruiti ormai fin dall’infanzia da una scienza pervertita dell’alimentazione, della chimica anabolizzante e dell’allenamento estremo, sono corpi ormai mostruosi che farebbero apparire gracile persino un gigante come Ali stesso, i quali si affrontano in qualcosa che assomiglia più alla lotta di poveri cani inferociti dalla cattività a cui li piega il talvolta orribile umano che ad una nobile arte, ora questi lottatori hanno nomi totemici che partono dalla tigre e vanno risalendo o percorrendo il catalogo degli animali più sanguinari feroci e mostruosi .
Muhammad Ali aveva scelto come animali totemici le farfalle e le api, la bellezza, la delicatezza e addirittura la fragilità per antonomasia e l’animale che rende possibile con la sua opera di fertilità impollinando i fiori, la stessa vita terrestre, l’ape. Un animale la cui arma è assolutamente difensiva, e la cui natura assolutamente sociale e non predatrice ma assolutamente collaboratrice. Qualcosa che certamente non sarà sfuggito ad Ali. Una scelta e una identificazione che non possono essere casuali. Animali totemici che verrebbero derisi in un lottatore sportivo dalla ferocia della violenza contemporanea contro la quale un eroe forte e buono come Muhammed Ali ha rappresentato un antidoto assoluto. Egli ha strappato in maniera inequivocabile e perentoria il combattimento dalla violenza. Anche , ripeto, rifiutando di offrire il suo corpo alla guerra ed evitando con ciò di edificare tra le due cose, tra guerra e combattimento sportivo, con il proprio corpo, un ponte semantico. Come dice Antonio nella testimonianza che ha dato nel suo video, molte sono le cose che si potrebbero dire, ne avremo certamente modo Antonio, per ora questo è solo il nostro minimo tributo alla grandezza di un uomo tanto forte quanto buono come Muhammad Ali.